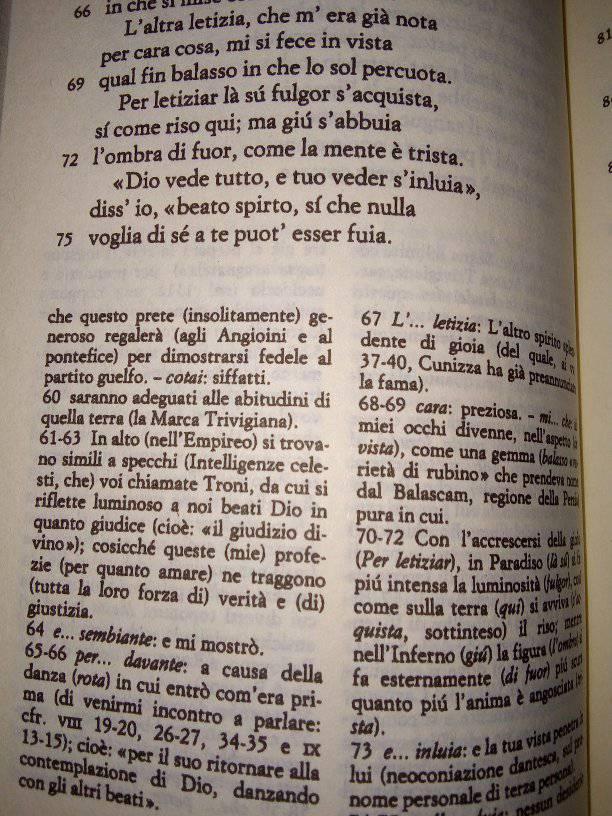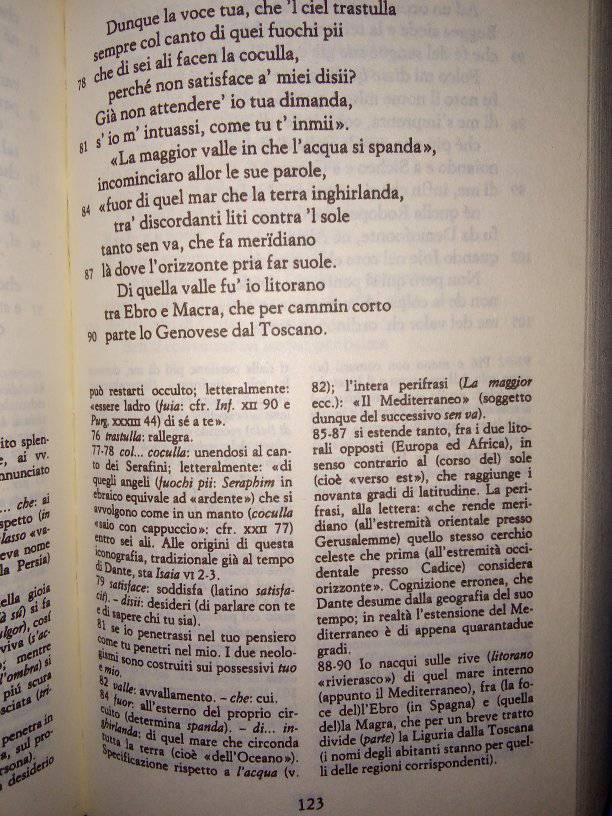Il canto XV dell’Inferno si svolge nel terzo girone del settimo cerchio, dove sono puniti i violenti contro Dio e nella fattispecie i sodomiti. Qua Dante incontra Brunetto Latini, concittadino, notaio e suo maestro di retorica negli anni fiorentini, le cui vite sono accomunate dall’aver vissuto l’esperienza dell’esilio. In un suo poemetto intitolato Tesoretto, scritto in volgare fiorentino, il Latini racconta di essere stato raggiunto dalla notizia della disfatta guelfa di Montaperti (la celebre battaglia combattuta il 4 Settembre nel 1260 a cui allude Dante con i celebri versi “lo strazio e ‘l grande scempio che fece l’Arbia colorata in rosso” Inf. XX, 86-87 ) a Roncisvalle, di ritorno dalla corte di Alfonso X di Castiglia presso cui era stato inviato in missione diplomatica per la parte guelfa della città di Firenze. La vittoria ghibellina costrinse Brunetto Latini a sei anni di esilio in Francia, dove soggiornò in varie località e dove, oltre al già citato poemetto, scrisse in lingua d’oil la sua opera nota, Il livre dou Tresor, indicato spesso con il titolo italianizzato di Tesoro. Mette conto notare che dell’omosessualità di Brunetto Latini ad oggi non vi è menzione se non nella Commedia. Questo è un dato significativo al fine di un’analisi contenutistica del canto, argomento su cui molto si è scritto e su cui qua non mi soffermerò, essendo questa un’introduzione alla lettura. Ciò che vorrei invece far notare è la mirabile struttura architettonica del canto, che ha le fondamenta nel dialogo tra il Poeta e Brunetto, splendidamente cesellato nella costruzione e denso di aspetti psicologici.
La pena dei sodomiti consiste nell’andare continuo su una landa sabbiosa rovente sotto una pioggia di fuoco ed è un andare eterno, perché qualora si arrestassero, sarebbero costretti a rimanere fermi per cento anni senza la possibilità di ripararsi dalle fiamme. Dante e Virgilio arrivano all’incontro con i dannati camminando lungo uno degli argini del Flegetonte, il fiume di sangue bollente che era stato introdotto nel canto precedente in una similitudine che richiama una sorgente termale, il Bulicame, ancora oggi attiva nei pressi di Viterbo, (“Quale del Bulicame esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici, tal per la rena giù sen giva quello”, Inf. XIV, 79- 81) ed è proprio il vapore che sale da questo a riparare i due dalla pioggia di fuoco. Il canto si apre con due similitudini di tipo geografico utili per rendere ancor più efficace l’immagine degli argini del Flegetonte (“Quale fiamminghi tra Guizzante e Bruggia […] E quali Padoan lungo la Brenta”) che sono paragonati ora alle dighe erette dai fiamminghi per difendersi dall’alta marea ora alle fortificazioni costruite lungo il fiume Brenta per proteggere le costruzioni abitate dalle esondazioni del fiume a seguito dello scioglimento delle nevi montane che ne ingrossano il corso. I due poeti incontrano qui la schiera dei sodomiti, che procedono ad un livello più basso rispetto a quello dell’argine e dalla quale si stacca uno dei dannati che, riconosciuto Dante, lo afferra per l’estremo lembo dell’abito ed esclama “Qual maraviglia!”. L’autore del gesto è Brunetto Latini, che sorpreso di incontrare il suo allievo in questo luogo esordisce con un’esclamazione di stupore. Il poeta si abbassa verso il dannato che lo ha appena riconosciuto per tentare di fare altrettanto e nonostante il volto di questo sia ormai arso dal fuoco vi riconosce il suo maestro degli anni giovanili. Trovo qui utile riportare per esteso i versi in cui l’incontro è descritto e soffermarmi su alcune scelte lessicali:
Così adocchiato da cotal famiglia,
fui conosciuto da un, che mi prese
per lo lembo e gridò: “Qual maraviglia!”.
E io, quando ’l suo braccio a me distese,
ficcaï li occhi per lo cotto aspetto,
sì che ’l viso abbrusciato non difese
la conoscenza süa al mio ’ntelletto;
e chinando la mano a la sua faccia,
rispuosi: “Siete voi qui, ser Brunetto?”.
E quelli: “O figliuol mio, non ti dispiaccia
se Brunetto Latino un poco teco
ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia”.
I’ dissi lui: “Quanto posso, ven preco;
e se volete che con voi m’asseggia,
faròl, se piace a costui che vo seco”.
Inf. XV, 22- 36
Efficace sia per la sua scelta che per la sua collocazione, opportunamente isolato dalle pause ritmiche, l’avverbio di luogo qui, così denso di significato e su cui si incardina l’intera terzina che lo contiene. Provate a leggere ad alta voce questo qui e vi sarà evidente tutto il suo valore, perfettamente funzionale all’espressione dello stupore, questa volta del poeta.
Le due terzine successive inaugurano quell’atmosfera familiare che pervaderà tutto il dialogo tra i personaggi, nel quale lo stupore iniziale lascia spazio alla dolcezza, resa efficacemente attraverso l’uso di espressioni come figliuol mio e ven preco. Dolcezza che è suggellata in una terzina collocata verso la chiusa del canto e contenente le parole commosse di Dante nel ricordare gli anni trascorsi ad imparare da Brunetto; parole che sono al contempo uno splendido inno a due altissimi valori, ugualmente eterni ed universali finché esisterà l’uomo: la cultura e l’amicizia.
“Se fosse tutto pieno il mio dimando”,
rispuos’io lui, “voi non sareste ancora
de l’umana natura posto in bando;
ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,
la cara e buona imagine paterna
di voi quando nel mondo ad ora ad ora
m’insegnavate come l’uom s’etterna:”
- 79- 85
Prima di riportare per esteso il canto, concludo facendo notare che questo è uno dei luoghi della Commedia in cui si profetizza l’esilio di Dante, questa volta per bocca di Brunetto, e non così distante dalla profezia di Farinata ascoltata nel canto X:
Ed elli a me: “Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorïoso porto,
se ben m’accorsi ne la vita bella;
e s’io non fossi sì per tempo morto,
veggendo il cielo a te così benigno,
dato t’avrei a l’opera conforto.
Ma quello ingrato popolo maligno
che discese di Fiesole ab antico,
e tiene ancor del monte e del macigno,
ti si farà, per tuo ben far, nimico;
ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi
si disconvien fruttare al dolce fico.
Vecchia fama nel mondo li chiama orbi;
gent’è avara, invidiosa e superba:
dai lor costumi fa che tu ti forbi.
La tua fortuna tanto onor ti serba,
che l’una parte e l’altra avranno fame
di te; ma lungi fia dal becco l’erba.
- 55- 72
Mette conto notare che questa profezia si avvia con una delle numerose esternazioni di consapevolezza del proprio ruolo di intellettuale e dell’altezza della propria produzione letteraria da parte del poeta, espressa qui tramite le parole del Latini:
Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorïoso porto,
se ben m’accorsi ne la vita bella;
Evidente come queste parole anticipino quelle forse più famose pronunciate da Cacciaguida nel XVII del Paradiso:
“questo tuo grido farà come vento”. Par. XVII, 133
che a loro volta arieggiano quelle almeno altrettanto note ed altissime di Orazio “Exegi monumentum aere perennius – Ho fatto un monumento che durerà più del bronzo”, Odi, 30, III.
Simone Salvi
Riportiamo qua per intero il canto XV.
Ora cen porta l’un de’ duri margini;
e ’l fummo del ruscel di sopra aduggia,
sì che dal foco salva l’acqua e li argini.
Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia,
temendo ’l fiotto che ’nver’ lor s’avventa,
fanno lo schermo perché ’l mar si fuggia;
e quali Padoan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli,
anzi che Carentana il caldo senta:
a tale imagine eran fatti quelli,
tutto che né sì alti né sì grossi,
qual che si fosse, lo maestro félli.
Già eravam da la selva rimossi
tanto, ch’i’ non avrei visto dov’era,
perch’io in dietro rivolto mi fossi,
quando incontrammo d’anime una schiera
che venian lungo l’argine, e ciascuna
ci riguardava come suol da sera
guardare uno altro sotto nuova luna;
e sì ver’ noi aguzzavan le ciglia
come ’l vecchio sartor fa ne la cruna.
Così adocchiato da cotal famiglia,
fui conosciuto da un, che mi prese
per lo lembo e gridò: “Qual maraviglia!”.
E io, quando ’l suo braccio a me distese,
ficcaï li occhi per lo cotto aspetto,
sì che ’l viso abbrusciato non difese
la conoscenza süa al mio ’ntelletto;
e chinando la mano a la sua faccia,
rispuosi: “Siete voi qui, ser Brunetto?“.
E quelli: “O figliuol mio, non ti dispiaccia
se Brunetto Latino un poco teco
ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia”.
I’ dissi lui: “Quanto posso, ven preco;
e se volete che con voi m’asseggia,
faròl, se piace a costui che vo seco”.
“O figliuol”, disse, “qual di questa greggia
s’arresta punto, giace poi cent’anni
sanz’arrostarsi quando ’l foco il feggia.
Però va oltre: i’ ti verrò a’ panni;
e poi rigiugnerò la mia masnada,
che va piangendo i suoi etterni danni”.
Io non osava scender de la strada
per andar par di lui; ma ’l capo chino
tenea com’uom che reverente vada. 45
El cominciò: “Qual fortuna o destino
anzi l’ultimo dì qua giù ti mena?
e chi è questi che mostra ’l cammino?”.
“Là sù di sopra, in la vita serena”,
rispuos’io lui, “mi smarri’ in una valle,
avanti che l’età mia fosse piena.
Pur ier mattina le volsi le spalle:
questi m’apparve, tornand’ïo in quella,
e reducemi a ca per questo calle”.
Ed elli a me: “Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorïoso porto,
se ben m’accorsi ne la vita bella;
e s’io non fossi sì per tempo morto,
veggendo il cielo a te così benigno,
dato t’avrei a l’opera conforto.
Ma quello ingrato popolo maligno
che discese di Fiesole ab antico,
e tiene ancor del monte e del macigno,
ti si farà, per tuo ben far, nimico;
ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi
si disconvien fruttare al dolce fico.
Vecchia fama nel mondo li chiama orbi;
gent’è avara, invidiosa e superba:
dai lor costumi fa che tu ti forbi.
La tua fortuna tanto onor ti serba,
che l’una parte e l’altra avranno fame
di te; ma lungi fia dal becco l’erba.
Faccian le bestie fiesolane strame
di lor medesme, e non tocchin la pianta,
s’alcuna surge ancora in lor letame,
in cui riviva la sementa santa
di que’ Roman che vi rimaser quando
fu fatto il nido di malizia tanta”.
“Se fosse tutto pieno il mio dimando”,
rispuos’io lui, “voi non sareste ancora
de l’umana natura posto in bando;
ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,
la cara e buona imagine paterna
di voi quando nel mondo ad ora ad ora 84
m’insegnavate come l’uom s’etterna:
e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo
convien che ne la mia lingua si scerna.
Ciò che narrate di mio corso scrivo,
e serbolo a chiosar con altro testo
a donna che saprà, s’a lei arrivo.
Tanto vogl’io che vi sia manifesto,
pur che mia coscïenza non mi garra,
ch’a la Fortuna, come vuol, son presto.
Non è nuova a li orecchi miei tal arra:
però giri Fortuna la sua rota
come le piace, e ’l villan la sua marra”.
Lo mio maestro allora in su la gota
destra si volse in dietro e riguardommi;
poi disse: “Bene ascolta chi la nota”.
Né per tanto di men parlando vommi
con ser Brunetto, e dimando chi sono
li suoi compagni più noti e più sommi.
Ed elli a me: “Saper d’alcuno è buono;
de li altri fia laudabile tacerci,
ché ’l tempo saria corto a tanto suono.
In somma sappi che tutti fur cherci
e litterati grandi e di gran fama,
d’un peccato medesmo al mondo lerci.
Priscian sen va con quella turba grama,
e Francesco d’Accorso anche; e vedervi,
s’avessi avuto di tal tigna brama,
colui potei che dal servo de’ servi
fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione,
dove lasciò li mal protesi nervi.
Di più direi; ma ’l venire e ’l sermone
più lungo esser non può, però ch’i’ veggio
là surger nuovo fummo del sabbione.
Gente vien con la quale esser non deggio.
Sieti raccomandato il mio Tesoro,
nel qual io vivo ancora, e più non cheggio”.
Poi si rivolse, e parve di coloro
che corrono a Verona il drappo verde
per la campagna; e parve di costoro
quelli che vince, non colui che perde.